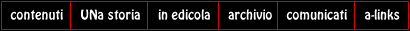Da "Umanità Nova" n. 43 del 22 dicembre 2002
Fiat
Movimenti scomposti in sala comandi
In una nave che affonda ci sono sempre viaggiatori di serie A e di
serie B, come ci ha insegnato la lunga saga cinematografica del Titanic.
Per i dirigenti ci sono liquidazioni milionarie (in euro, s'intende) e
probabili contratti di consulenza esterna. Per gli operai la
mobilità lunga (2.600 persone) e la c.i.g. a zero ore con fumose
possibilità di rientro (5.600 persone). Per Cantarella si era
parlato, nel giugno scorso, di una ventina di miliardi di vecchie lire,
da erogarsi in più tranche nell'arco di tre anni. Cantarella
veniva da un disastro, ma era uno di famiglia, avendo sposato una Nasi.
Per fare fuori Romiti, quattro anni prima, ne erano serviti quasi mille,
di miliardi di vecchie lire, ma allora (nel 1998) i bilanci
consentivano qualche generosità, lo stato di servizio era
abbastanza lungo e i servizi resi considerevoli, avendo resuscitato
l'azienda per un paio di volte, correndo anche qualche rischio
personale. Di Galateri di Genola non si sa ancora l'entità della
liquidazione, d'altronde il ragazzo resta nel Consiglio
d'Amministrazione di Fiat e prende anche la presidenza dell'Ifi. Fresco
pare venga liquidato fra sei mesi con circa 110 milioni di euro, il
controvalore di 200 miliardi di lire. Occhio e croce, può essere
la cinquantesima parte di ciò che ha fatto perdere ai suoi
mandanti negli ultimi tre anni. Così va il mondo dalle parti del
Lingotto, oggi.
Proviamo a ricostruire quanto è accaduto nella prima decade di
dicembre, ad un anno esatto dallo scoppio della crisi che aveva portato
al licenziamento di Testore, al primo inutile aumento di capitale, al
decisivo ingresso nel tunnel del coma aziendale.
Quello che è facilmente decifrabile è la
conclusione della "vertenza": l'accordo tra la Fiat ed il governo
denuncia senza infingimenti che trattativa non c'è stata, le
decisioni aziendali sono state avvallate dal governo, la Fiat ottiene
tutto ciò che si era proposta. Le cifre degli esuberi combaciano
con le intenzioni iniziali dell'azienda, l'unica "novità"
è l'impegno a riaprire Termini Imprese dopo 9 mesi anziché
un anno, se il mercato lo consente e dirottandovi linee di produzioni
previste a Mirafiori. La regionalizzazione del conflitto ha premiato (si
fa per dire) il sud a scapito del nord. Nessuno si illude sulla
serietà dell'impegno aziendale. Lo stato dell'azienda rimane
comatoso, l'intervento dello stato si limita a sborsare i quattrini
chiesti dall'azienda: 50 milioni di euro per cig a zero ore e
mobilità lunga, 60 milioni di euro per i corsi di formazione e
riqualificazione. In tutto sono 110 milioni di euro: grosso modo, la
liquidazione di Fresco.
Quello che ha stupito di più è stato l'intricato scontro
di potere tra i "vincitori" apertosi subito dopo la firma dell'accordo
tra il governo e la Fiat: il tentativo di ribaltone, la defenestrazione
dei vertici, il compromesso finale. Che bisogno c'era di aprire adesso
questa faida trasversale?
Per capire qualcosa degli interessi che oggi gravitano sul Lingotto e interpretarne le scelte può essere utile fare il confronto con la situazione precedente. Cinquant'anni fa Fiat era il perno del capitalismo privato italiano, garanzia di fedeltà atlantica nello schieramento internazionale, punta di diamante di un modello di sviluppo industriale da costruire: sintetizzava innovazione tecnologica e guida politica. La Fiat condizionava il sistema politico, usava a piacimento le strutture dello stato, asserviva polizia e magistratura, violava leggi e contratti, controllava direttamente o indirettamente l'informazione. Era impossibile mettersi contro la Fiat: sfidarla significava rischiare tantissimo. Persino le organizzazioni più solide del movimento operaio erano costrette ad arretrare davanti alla sua forza e quando non lo facevano sperimentavano sconfitte storiche. Le partecipazioni statali lavoravano in funzione della Fiat: le autostrade servivano per articolare il suo modello di trasporto, la siderurgia pubblica per produrre le lamiere necessarie alle auto, la rete distributiva dell'Eni per fornire la benzina alle vetture Fiat. Era un modello che non accettava mediazioni, ma insieme a repressione e licenziamenti per rappresaglia, la Fiat dispensava anche i salari più alti di Torino e, con le dovute eccezioni, d'Italia. Ma la Fiat è stata sempre più temuta che amata.
Le vicende degli ultimi mesi lo dimostrano ampiamente. La denuncia di Fresco di aver subito un linciaggio mediatico e politico corrisponde in gran parte a verità e rappresenta lo sfogo naturale rispetto ad almeno 100 anni di angherie subite in silenzio. In ogni bar d'Italia esiste una ricetta per la Fiat, ma quello che più stupisce è la dissacrazione del sistema Fiat avvenuta in luoghi inconsueti: le agenzie di rating, le banche creditrici, Il Parlamento, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero del Welfare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla fine tutti hanno fatto ciò che Fiat chiedeva, come non si nega l'ultimo desiderio ad un moribondo: ma prima glie ne hanno dette davvero tante. E tutto lascia presagire che non è ancora finita.
In questo baillame la proprietà ha cercato di sfuggire all'accerchiamento, utilizzando uno contro l'altro i "soccorritori" ansiosi di spartirsi le spoglie del caro estinto, cercando di cambiare le alleanze. La famiglia Agnelli, capitanata ormai da Umberto Agnelli, ha deciso di sacrificare il "suo" liquidatore di fiducia (Galateri di Genola) nell'estremo tentativo di dribblare il suo destino, ormai nelle salde mani di banche e General Motors, Questo tentativo è andato a vuoto. Capire il perché può essere di qualche aiuto per prevedere l'esito finale di questa drammatica vicenda.
Nel maggio scorso Fiat rinegozia con le banche il suo debito a
breve. Le principali quattro banche italiane prestano a Fiat 3 miliardi
di euro, ma richiedono, pretendono, impongono precisi impegni e
garanzie. La Fiat deve far scendere il suo debito entro pochi mesi (18),
vendendo tutto ciò che è vendibile. Se questo non accade
il prestito si trasforma in azioni, il pacchetto di controllo passa alle
banche, gli Agnelli vengono estromessi. La garanzia finale per le
banche si chiama GM: dal 2004 scatta l'opzione put, gli americani devono
comprarsi il restante 80% di Fiat Auto, le banche mettono i propri
crediti in mano ad un soggetto di ben altra solidità. Della
sorte degli Agnelli, non se ne fotte più nessuno.
Naturalmente questo accordo alla famiglia non piace. Partono
le manovre per trovare altre strade. Scatta il riavvicinamento a
Mediobanca, che si compra "cash" un pezzo della Ferrari, facendo
imbestialire sia le altre banche, che il governatore Fazio. Mediobanca
non può assumere partecipazioni industriali, ma evidentemente
vuole rientrare nella partita, dopo anni di gelo nei rapporti con
Umberto Agnelli. Nel periodo successivo la vicenda si arricchisce di
nuove puntate. La situazione di mercato di Fiat peggiora ancora, il calo
delle vendite la porta al 20% del mercato italiano e al 7% del mercato
europeo: si profila un rischio fallimento. Si deve chiedere aiuto al
governo, le banche premono per ottenere dismissioniche non vengono
realizzate, la situazione sta precipitando. La GM svaluta del 90% la
propria quota in Fiat Auto: è un chiaro segnale di volersi
comprare a costo zero un'azienda ormai decotta. L'accordo con il governo
per la gestione della crisi lascia trapelare un atteggiamento molto
ostile da parte di Berlusconi, che mira allo spezzatino del gruppo per
potersi incamerare Hdp-Rizzoli.Corsera, nonché alla
possibilità di sfruttare la vendita della Toro per mettere le
mani su pezzi di Mediobanca/Generali attraverso Mediolanum. Il fronte
dei nemici si allarga: la gestione Fiat viene criticata in modo frontale
da tutto lo schieramento politico, si profila il rischio concreto che
la famiglia venga buttata fuori dall'azienda in pessimo modo.
Scatta la controffensiva, studiata da Mediobanca, una "maison"
specializzata nel "salvare" aziende decotte con il massimo profitto per
le sue strategie di potere: la storia della Ferruzzi, affossata e
assorbita, insegna.
La proposta a Umberto Agnelli è semplice e articolata: fare
fuori l'intero vertice (Galateri e Fresco), sostituirlo con un uomo di
fiducia a testa (Bondi per Mediobanca e Gabetti per gli Agnelli),
cambiare le alleanze, trovare soldi freschi e sventare il piano
industriale appoggiato dalle banche, sfruttare l'italianità della
Fiat, costringere la GM a rinunciare all'opzione di acquisto, fondere
Ferrari-Maserati-Alfa per costruire il polo del lusso in mano alla Fiat
per il 51% e fare entrare la Volkswagen al 49%, insomma scompaginare
completamente le carte e salvare (almeno temporaneamente) la famiglia
Agnelli, tutto ciò con il sostanziale appoggio del governo.
Un cambiamento di strategia di questa portata ha scatenato, prevedibilmente, un putiferio.
Mediobanca si propone come nuovo interlocutore di riferimento
della famiglia, rispolverando i fasti di un tempo. Ma oggi non ha
più tre banche di interesse nazionale al suo servizio, come ai
bei tempi. Anzi, le ha contro. Sono state la banche a bloccare la
manovra, perché insieme hanno oltre 10 miliardi di euro di debiti
da incassare e sanno di poterlo fare solo se, alla fine, GM
comprerà. Senza questa garanzia Fiat Auto sarebbe, probabilmente
già fallita. Sono state le banche a porre la fiducia su Fresco,
almeno sino a quando avrà finito il compito per cui si è
impegnato: vendere tutto il possibile, compresa, a questo punto, anche
la Toro. Sul futuro della famiglia ci sono, a questo punto, molte
più incognite: è fallito il tentativo di smarcarsi da Fiat
Auto senza pagare nulla per i danni combinati. Se saranno costretti a
vendere la Toro, la Fidis, il Club Mediterranee, l'Arjo Wiggins, la
quota residua in Italenergia, insomma tutto quello che è rimasto
di sano nel gruppo, e girare il ricavato nel rimborso dei debiti
contratti con le banche e i risparmiatori privati, potremmo veramente
trovarci con un futuro sgravato dall'ingombrante presenza della famiglia
Agnelli.
Ma sarebbe davvero un sogno troppo bello. È meglio restare con i
piedi per terra. È più realistico pensare che Fresco abbia
un mandato a tempo, che la famiglia riesca in qualche modo a ricavare
qualcosa dalla vendita di Fiat Auto e che riesca a salvare qualcosa del
suo imponente impero. Cercheranno probabilmente di conservare con le
unghie e con i denti almeno Italenergia, anche se il partner industriale
che si sono scelti (l'Edf francese) sembra finanziariamente assai
più solido e in generale più ricco di futuro.
In questo scontro tra titani hanno sicuramente la peggio i cassaintegrati della Fiat, che pur avendo avuto la benedizione berlusconiana nel cercarsi un "lavoretto" per arrotondare, hanno come concreta prospettiva quella di perdere il proprio posto di lavoro. La "stabilità" della tolda di comando, salutata con entusiasmo dal governo e dall'opposizione, dalle banche e dalla General Motors, si traduce nella nomina ad Amministratore Delegato di Alessandro Barberis, un uomo Fiat da 38 anni, negoziatore diretto dell'accordo con il governo. Una sicura garanzia per attuare il piano industriale concordato, cioè licenziare e chiudere, liquidare e vendere. Non più auto, ma Fiat Auto. Una differenza non da poco.
Renato Strumia