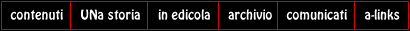Da "Umanità Nova" n. 43 del 22 dicembre 2002
Operazione
Babilonia/1
Guerra all’Iraq o all’Arabia Saudita?
Pubblichiamo la prima parte
di un lungo saggio di Giacomo Catrame dedicato al contesto geopolitico
in cui si inserisce la guerra che gli Stati Uniti si accingono a
scatenare contro l'Iraq.
GUERRA ALL'IRAQ O ALL'ARABIA SAUDITA?
Come è ormai ampiamente noto gli Stati Uniti hanno vinto la prima mano della partita denominata "guerra all'Iraq". La risoluzione dell'ONU, infatti, non autorizza l'automatico intervento militare contro l'Iraq, come ufficialmente richiesto dagli USA e dalla Gran Bretagna, ma pone tali condizioni al governo del dittatore Saddam Hussein da permettere qualsiasi provocazione da parte di un qualsiasi agente della CIA travestito da ispettore dell'ONU. D'altra parte è abbastanza chiaro che Bush e Blair hanno puntato su una posizione massimalista per ottenere da Francia, Russia e Cina una risoluzione ufficialmente più morbida ma le cui conseguenze portano esattamente alle stesse conclusioni volute da Londra e Washington.
La guerra, quindi, per ora è rimandata ma sicuramente ci sarà. È solo questione di tempo.
La pervicacia con la quale l'amministrazione Bush (e quella del maggiordomo Blair) cercano il conflitto definitivo con lo stato mediorientale non si può spiegare né con le menzogne utilizzate da questi governi come giustificazioni, né con l'analisi più in voga nella stampa indipendente che vede questa volontà nascere dal semplice desiderio anglo-americano di appropriarsi di alcuni giacimenti petroliferi.
Il petrolio, infatti, centra, ma non tanto come semplice obiettivo, quanto come vero e proprio strumento di guerra per ottenere la risistemazione della carta geopolitica del Medio oriente secondo gli interessi della superpotenza globale e del suo fido alleato europeo.
La visione geopolitica che si è affermata a Washington
negli ultimi anni ha subito una drammatizzazione con gli attentati
dell'11 settembre, ma è maturata ben prima del doppio schianto
aereo dello scorso anno.
I motivi che hanno portato alla costruzione di questa nuova visione
dell'ordine del Medio Oriente da parte degli americani sono da
ricercarsi nella crisi di fiducia di questi ultimi verso la leadership
saudita, motivata dai dubbi sulla tenuta della famiglia Saud, dal
tentativo della diplomazia di Riyad di intromettersi nel conflitto
israelo-palestinese, dall'incerta situazione economica americana che
abbisogna di ulteriori riduzioni dei prezzi petroliferi oggi come oggi
impediti dall'OPEC e dal rischio di incontrollabilità del Golfo
Persico attualmente una delle vie principali di trasferimento del
greggio verso l'Occidente.
Con la dichiarazione di "Guerra infinita al terrorismo" gli Stati Uniti hanno costruito uno scenario mondiale inedito all'interno del quale hanno assunto il ruolo di protagonisti assoluti. La prima priorità che il governo di Washington ha assunto in questo quadro è stata quella dell'indipendenza energetica, con la conseguenza di costringerli ad aprire il "dossier Arabia Saudita". Come i governanti americani ben sapevano, infatti, i sauditi finanziano da almeno due decenni le reti terroristiche internazionali legate alla corrente islamica wahabita (la stessa alla quale appartengono i regnanti sauditi) e lavorano fin dal 1980 alla diffusione delle proprie reti politico-religiose in quell'Asia Centrale che sembra destinata a diventare particolarmente importante dal punto di vista energetico nel futuro immediato.
L'Arabia Saudita, quindi, si presenta con le caratteristiche
di "stato canaglia" per gli USA ben più di Iraq e Iran. Inoltre
l'amministrazione americana è sempre stata perfettamente a
conoscenza dell'operato saudita dal momento che la CIA ha attivamente
collaborato alla costruzione di queste reti ai tempi della "Guerra
santa" contro l'URSS e che il finanziamento di Washington è stato
fondamentale per la loro attivazione.
Il problema centrale per gli Stati Uniti, ampiamente incomprensibile
per i sostenitori delle teorie che hanno il loro centro nella negazione
del ruolo degli stati, è la connessione tra l'Arabia Saudita e
l'Occidente fatta di filiere finanziarie internazionali e del ruolo di
calmiere del prezzo petrolifero assunto da questo paese.
L'intenzione americana di punire l'Arabia Saudita per il ruolo
di opposizione coperta alla politica americana non può quindi
consistere in una guerra contro lo stato della penisola arabica, ma
inizia ad assumere in modo scoperto le fattezze della demolizione del
meccanismo di controllo del prezzo petrolifero incarnato dall'OPEC.
L'operazione geopolitica americana è quella di colpire le
opposizioni arabe al proprio dominio incontrastato in Medio oriente
tramite il petrolio, immettendo sul mercato significative
quantità di greggio capaci di far saltare il delicato meccanismo
che governa l'offerta (e, quindi, il prezzo) di petrolio. Queste
risorse, però, per ottenere lo scopo preventivato devono
provenire da ricchi giacimenti a basso prezzo di estrazione e vicini
alle infrastrutture di trasporto. Al mondo esiste solo un luogo che
assommi queste caratteristiche: l'Iraq. Per punire l'Arabia Saudita,
quindi, agli americani serve l'Iraq e il suo petrolio.
IL SISTEMA DEI TRE MARI
La guerra americana per rendersi indipendenti dal punto di
vista energetico è iniziata con la guerra del Golfo del 1991.
Allora gli USA pensarono che la "liberazione" del Kuwait, la distruzione
del potenziale bellico dell'Iraq e l'occupazione di fatto dell'Arabia
Saudita (da allora sono presenti sul territorio saudita sono presenti
35.000 soldati americani) bastasse a garantirsi il controllo delle
risorse energetiche dell'area.
A partire dalla metà degli anni novanta, però, gli Stati
uniti hanno iniziato a rendersi conto che la prima guerra contro Saddam
non era bastata né a stabilire il controllo sulle risorse
mediorientali, né a risolvere le questioni legate alle risorse
energetiche alternative a quelle della penisola arabica presenti in Asia
Centrale.
Risale a quell'epoca il battesimo del sistema geopolitica detto dei
"Tre mari" (Adriatico, Nero e Caspio) dal quale dipende il controllo del
trasporto del greggio dell'Asia Centrale e l'avvio della battaglia per
stabilire il dominio di Washington su di esso. Inizialmente gli USA
hanno giocato la carta della contrapposizione contro la Russia il cui
episodio più significativo è stata la guerra del Kosovo.
L'obiettivo di questa continuazione della Guerra Fredda era quello di
valorizzare e rendere commercializzabili attraverso il Mediterraneo le
risorse petrolifere del Caspio non russo né iraniano. La base di
quest'operazione è stato l'Azerbaigian, tramite il quale
Washington ha "agganciato gli altri stati dell'area (Georgia,
Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan) sottraendoli all'orbita di Mosca.
Naturalmente questa operazione ha rafforzato il ruolo della Turchia,
principale alleato di Washington nell'area, secondo esercito della NATO
e affidabile traghettatore del petrolio centroasiatico. Non a caso in
quegli anni nasce in Turchia il progetto "grande Turan" che mirava a
costruire una sorta di Commonwealth tra le popolazioni turcofone
dell'Asia Centrale con base ad Ankara. A quest'operazione, fatta di
investimenti per percorsi per il trasporto energetico che evitassero il
territorio russo e quello iraniano e di sabotaggio dell'uso degli
oleodotto e dei gasdotti russi, non è estranea nemmeno la guerra
in Cecenia, dal momento che la guerriglia cecena è stata per anni
addestrata e finanziata (in un rapporto di collaborazione e insieme di
competizione) da turchi e sauditi sotto la supervisione della CIA e la
longa manus di Condoleeza Rice, oggi ministro dell'amministrazione Bush
e allora consigliera per l'area della compagnia petrolifera
Chevron-Texaco. Il progetto americano dell'epoca era quello di replicare
in seguito questa operazione in Asia Centrale, questa volta in funzione
anticinese. Inizialmente l'operazione in Afganistan dopo l'11 settembre
è stata coerente con questa visione, soprattutto per quanto
riguarda l'opposizione alla crescita della Cina come potenza regionale.
I rapporti russo-americani, però, hanno avuto un significativo
mutamento nel corso dell'anno seguito all'11 settembre. In primo luogo
sono mutati i rapporti tra le compagnie petrolifere anglo-americane
presenti nell'area (Chevron-Texaco, Shell) e i due giganti russi,
Lukoil e Jukos, oggi orientati a una stretta collaborazione basata sul
riequilibrio degli interessi economici dei due paesi, pagato dalla
Russia con l'accettazione della propria marginalità sul piano
geopolitica globale.
La Russia, comunque, ha portato a casa alcuni importanti risultati per quanto riguarda la questione degli oleodotti: la realizzazione dell'oleodotto Tengiz (in Kazakistan) – Novorossijsk (porto russo sul Mar Nero) grazie all'impegno di un consorzio internazionale, la modernizzazione (svolta in condominio con le compagnie angloamericane) della rete energetica dei paesi ex sovietici dell'Asia Centrale, la spartizione delle piattaforme petrolifere con Azerbaigian e Kazakistan e la costruzione del gasdotto sottomarino Bluestream che congiunge Russia e Turchia attraverso il Mar Nero. Costruzione quest'ultima svolta dall'Eni. Inoltre la Russia è rientrata nel sistema di trasporti petroliferi che toccano l'Adriatico (dal quale era stata espulsa con la guerra del Kosovo e la successiva caduta di Milosevic) grazie all'accordo con la Croazia che permette l'aggancio del circuito petrolifero Russia-Europa con quello che da Belgrado porta a Zagabria e da lì all'Italia.
Gli americani, per la loro parte, hanno ottenuto la partecipazione russa (e quindi la non opposizione di Mosca) alla costruzione del megaoleodotto Baku (nell'Azerbaigian) - Ceyhan (porto turco sul Mediterraneo. Se il "gioco dei tre mari" cambia le sue carte, trasformando l'avversario di ieri (debitamente ridimensionato) in alleato, non cambia però il nome del maggior beneficiario dell'area, quella Turchia che vede ampliarsi il suo ruolo nevralgico come custode degli oleodotti principali (e di molti di quelli in costruzione) della regione.
In questo modo gli americani hanno raggiunto il primo dei loro obiettivi, stabilizzando il sistema dei tre mari, convogliando la gran parte delle risorse energetiche dell'area verso il principale alleato mediorientale: la Turchia. La sicurezza americana all'interno di questo settore del "gioco" è tale che a marzo di quest'anno anche il gas iraniano ha ricominciato a fluire verso la Grecia tramite la Turchia. Il risultato di stabilizzazione è stato tale che l'intera politica energetica americana in Medio Oriente può essere descritta in questo slogan: "far confluire il greggio e il gas del Medio oriente verso il mediterraneo, evitando a ogni costo che si diriga verso il Golfo Persico". Ritornando alla principale questione di quest'articolo, la prossima guerra in Iraq, bisogna ricordare che l'intero sistema di trasporto energetico di questo paese è direzionato sia verso il Mediterraneo che verso il Golfo; in coerenza con la politica dei tre mari quando si trattò di decidere quale dovesse essere l'oleodotto da utilizzare per far fluire il petrolio necessario all'attivazione del programma Oil for Food gli americani fecero pesanti pressioni fino ad ottenere la scelta della tratta Kirkuk-Ceyhan a scapito di quella Bassora-Fao (porto sul Golfo Persico).
Giacomo Catrame