3.1 DIRITTI UMANI DELLE DONNE
Nell'evoluzione del movimento globale delle donne, il termine
"diritti umani delle donne" ha avuto un notevole impatto
come strumento per l'attivismo politico. Ha rappresentato, infatti,
un punto di convergenza, un terreno comune, al di là dei
confini geografici, per la realizzazione di concrete strategie
politiche volte al cambiamento ed ha facilitato la creazione
di strategie collaborative, formate dall'interazione tra spunti
analitici e pratiche politiche, per la promozione e la difesa
dei diritti umani in una dimensione specificatamente di genere.
Nel tracciare un breve cenno storico sulle origini dei networks
di solidarietà di genere su larga base internazionale
e, quindi, sull'idea di una prospettiva di genere dei diritti
umani, si deve risalire alla più volte citata Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite nel 1948.
Stante la polarizzazione delle posizioni avvenuta durante la
Guerra Fredda, i governi occidentali attribuirono priorità
ai diritti civili e politici mentre i diritti socio-economici,
quali il diritto al lavoro, alla casa ed alla salute, furono
identificati con il blocco socialista e, per questo, guardati
con sospetto. Ciò eclissò i modi in cui le donne
spesso non godevano delle condizioni sociali ed economiche necessarie
per poter partecipare alla vita pubblica ed essere partner a
pieno titolo e su un piede di uguaglianza con gli uomini per
i diritti di accesso a risorse e opportunità (1).
Nel desiderio di limitare la giurisdizione degli stati, inoltre,
alla base della Dichiarazione è stata posta la divisione
tra pubblico e privato: le violazioni dei diritti umani delle
donne che avvengono tra "privati" cittadini sono state,
così, rese invisibili nonché considerate come al
di là della supervisione dello Stato.
Sottolineare quest'ultimo passaggio è rilevante ai fini
del lavoro, poiché i gravi abusi perpetrati alla donne
in nome della religione e della cultura sono stati occultati,
e purtroppo lo sono spesso tuttora, dalla santità della
sfera cosiddetta "privata" (2).
Solo con l'irruzione sulla scena del movimento femminista negli
anni '70, questa visione tradizionale è posta in discussione
grazie alla definizione di un nuovo approccio noto come "Women
in Development" (WID) che sottolinea come non si possa
parlare di sviluppo escludendo l'ottica di una partecipazione
piena della donna che, finalmente, cessa di essere vista solo
come passiva beneficiaria di politiche di aiuto e di assistenza.
È sostanzialmente su questo orientamento che si incardina
la sequenza delle quattro conferenze sulla donna convocate dall'Onu
nel ventennio 1975-95 (3) e, soprattutto, il lancio da parte
dell'Assemblea Generale dell'Onu del Decennio delle Donne 1976-1985
(4).
Si è trattato di importanti momenti di svolta in cui le
donne si sono incontrate, hanno discusso le proprie differenze,
hanno scoperto i problemi in comune e gradualmente cominciato
a tenere insieme le differenze con la creazione di un movimento
globale.
Nei tardi anni '80 e nei primi anni '90, donne di diversi paesi
hanno interrogato la cornice dei diritti umani e sviluppato strumenti
analitici e politici che, assieme, costituiscono l'idea e la
pratica dei diritti umani delle donne in un'ottica nuova definita
di "Genere e sviluppo": l'obiettivo non è più
semplicemente la partecipazione delle donne allo sviluppo ma
la genderizzazione dello sviluppo stesso, ovvero l'inclusione
di prospettive di genere nello sviluppo e nell'implementazione
della politica dei diritti umani (5).
La definizione degli abusi perpetrati alle donne nell'ambito
dei diritti umani stabilisce inequivocabilmente che gli stati
sono responsabili della loro cessazione e il concetto di universalità
degli stessi sfida la pretesa che la denuncia delle violenze
contro le donne possa essere limitata da specifiche definizioni
culturali o religiose sul ruolo femminile nella società.
La dichiarazione di Vienna (1993) e il Programma d'Azione che
fu il prodotto della Conferenza quale segnale d'accordo della
comunità internazionale sullo stato dei diritti umani,
attesta inequivocabilmente che: ÅgI diritti umani
delle donne e delle bambine sono un'inalienabile, integrale ed
indivisibile parte dei diritti umani universali" (Dichiarazione
di Vienna. I, 18, 1993).
È importante precisare che gli accordi che le conferenze
sopra citate hanno prodotto non hanno valore giuridico vincolante,
ma molti di essi hanno rappresentato rilevanti strumenti politici,
utilizzati sia dai governi che dai movimenti delle donne di tutto
il mondo, sia a livello internazionale che nelle proposte politiche
a livello nazionale e locale.
Ad esempio, questi documenti sono stati utilizzati per rinforzare
ed interpretare i trattati internazionali che, sottoscritti da
uno Stato, assumono lo status di legge internazionale.
Il trattato internazionale più importante che si rifà
ai diritti umani delle donne è
la " Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione
verso le donne" (CEDAW) che è stata ratificata da
130 paesi, Afghanistan compreso.
Per concludere, ripercorrere brevemente la storia dei diritti
umani delle donne è indispensabile per chiarire le origini
di un movimento di genere divenuto globale. I princìpi
fondamentali dei diritti umani, che accordano a ciascuna persona
la dignità umana, forniscono alle donne un vocabolario
per descrivere le violazioni ai loro diritti umani e gli impedimenti
che esse incontrano per esercitarli; è un linguaggio che
le mette in grado di articolare la specificità delle esperienze
nelle loro vite, di condividere tali esperienze con altre donne
nel mondo e di lavorare collaborativamente per il cambiamento
(6) .
3.2 I DIRITTI DELLE DONNE ISLAMICHE
"...Oh, voi che credete, siate timorati del vostro Signore,
il Quale vi ha creato da un solo individuo, dal quale ha creato
il suo compagno (di sesso femminile); le due unità della
coppia da cui ha prodotto molti uomini e donne...."
(Corano 4,1)
"....Egli (Dio) è Colui che vi creò da
un unico individuo, dal quale trasse la sua compagna perchè
in essa trovasse rifugio (nell'amore)...."
(Corano 7,189)
"....Ed Allah vi ha dato compagne della vostra stessa
natura, e vi ha dato dalle vostre compagne figli e nipoti, ed
ha provveduto a voi con ogni sorta di buone cose. E' dunque invano
che essi credono è per grazia di Dio che essi non credono?
(Corano 16,72)
"....E tra i Suoi Segni vi è questo: Che Egli
creò compagne per voi in cui possiate trovare riposo,
pace mentale in esse, ed Egli ordinò tra voi amore e misericordia.
Ecco, qui vi sono invero segni per le persone che riflettono...."
(Corano 30,21)
Il tema dei diritti delle donne nell'Islam è al centro
di accesi dibattiti e di giudizi estremamente contrastanti. Laddove
le leggi del Corano sono applicate più rigidamente non
è facile parlare di "diritti" delle donne islamiche
dal momento che la maggior parte di esse sono private delle più
elementari norme civili : dalla minore libertà di spostamento
alla minore libertà d'espressione, di parola, di saluto;
minore possibilità di avanzare negli studi o nella carriera
e di rivestire cariche o ruoli di responsabilità in ambito
civile o religioso; quasi nessuna possibilità di partecipare
alla vita politica o di venire eletta; scarsa possibilità
di decidere il proprio destino o quello dei propri figli; sottomissione
all'uomo, da cui può venire ripudiata (e non viceversa);
convivenza con altre mogli scelte dall'uomo; obbligo, in molti
paesi, di coprire il proprio corpo e spesso anche il viso; imposizione,
in molti paesi, dell'infibulazione e dell'escissione; frequenti
gravidanze non scelte liberamente, ma imposte dal marito.
Tuttavia, per evitare di incorrere in facili stereotipi, occorre
specificare che nel messaggio islamico sono insite due tendenze
divergenti, due concezioni contrastanti dei sessi, una si esprime
nelle regole pratiche destinate alla società, l'altra
nell'elaborazione della concezione etica.
Quando le rivelazioni del Profeta sul matrimonio istituirono
una struttura gerarchica come base dei rapporti tra uomini e
donne, esse predicarono contemporaneamente (come nel caso del
giudaismo e del cristianesimo) l'uguaglianza morale e spirituale
di tutti gli esseri umani (7).
L'Islam di Maometto metteva al bando l'idea di sorveglianza,
di sistema poliziesco di controllo, e questo spiega anche l'assenza
di clero e l'incoraggiamento rivolto ad ogni musulmano a cavarsela
da solo nella comprensione del testo.
La responsabilità individuale equilibrava il peso del
controllo aristocratico, rendendolo alla fine inutile, in un
Umma (nazione di eguali) di credenti la cui condotta obbediva
a regole precise e interiorizzate. Riconoscere alla donna una
volontà inalienabile rientrava in questa strategia di
responsabilizzazione globale nell'ambito di una dimensione dell'Islam
come civiltà e riflessione sull'individuo e sul ruolo
di questo nella società (8).
Purtroppo, però, sono state le regole pratiche, che costituiscono
l'interpretazione tecnica dell'Islam, ad essere ampiamente elaborate
nel pensiero politico e giuridico, e questa versione legalistica
e ufficiale, che trascende ampiamente gli aspetti etici del messaggio
del Profeta, conserva ancora oggi la sua forte influenza politica.
L'Islam avrebbe potuto introdurre mutamenti solo ed esclusivamente
nella sfera pubblica e spirituale ma non nella vita privata e
nell'ambito familiare dove hanno prevalso, fino ai giorni nostri,
i pregiudizi misogini e androcentrici dell'Arabia pre-islamica
Così la visione del femminile si esprime attraverso un
sistema di superstizioni e credenze che Maometto voleva condannare
in quanto fondamento dell'essenza della Jahiliya (l'epoca
dell'ignoranza). Ad esempio, la sessualità e, in particolare,
la donna durante il ciclo mestruale, sono considerate una fonte
di contaminazione e impurità, un polo di forze negative.
A forza di soffocare la propria soggettività, inoltre,
i Fuqaha (interpreti religiosi)(9) furono costretti ad
accumulare i casi e le diverse opinioni. Poiché veniva
accordato a tutti il diritto di avere il proprio parere, nacque
una vera e propria letteratura fatta di opinioni giustapposte.
La letteratura religiosa ha voluto essere scientifica ma sarà
una scienza empirica, in cui ogni redattore si limiterà
a collezionare senza ricavare sintesi che ci aiutino a "discernere"
l'essenziale dal secondario. E, ciò facendo, aprirà
la via alle manipolazioni per mezzo delle interpretazioni, all'uso
che gli uomini fanno del sacro per legittimare alcuni privilegi
di natura politica e sessuale, come nel caso esemplare del regime
dei comandanti dell'Alleanza del Nord o dei talebani afghani.
Tra le cause relative alla nascita di fondamentalismi o estremismi
confessionali c'è sempre una reinterpretazione e rielaborazione
sul piano teologico, spesso piegata ad interessi particolaristici
come nel caso degli Ulema (i teologi islamici) che, nel
tempo, si staccarono dai moniti evolutivi del Corano per assicurarsi
potere e prestigio personale.
Bandirono la Igtihad (libera discussione in fatto di religione)
per trasformare il concetto di Igma (consenso della comunità)
in consenso dei dotti, ossia di loro stessi. Restrinsero il concetto
di Ilm (conoscenza) al fatto religioso escludendolo dalla
vastità del sapere (10).
Così, il sistema sociale, cui ha dato origine la concezione
della differenza tra i sessi dell'islam tradizionale, ha posto
le donne a tutti i livelli -culturale, giuridico, sociale ed
istituzionale- in una posizione controllata e subordinata emarginandole
economicamente e le ha concepite come esseri inferiori agli uomini
(11).
Solo con queste premesse si può comprendere il senso dello
Hijab (12) (letteralmente "cortina") che rappresenta
un concetto chiave della civiltà musulmana come quello
di peccato in quella cristiana.
Lo Hijab è "disceso" per porre una barriera
non tra un uomo ed una donna, ma per separare lo spazio tra due
uomini nell'ottica di una scissione tra pubblico e privato: rappresentava
l'incarnazione dell'assenza del controllo interno, il velo della
volontà sovrana, fonte di discernimento e di ordine nella
società. Il termine, invece, ridotto e assimilato ad uno
straccio che gli uomini hanno imposto alle donne per velarle
quando camminano per strada, è stato impoverito o addirittura,
in alcuni casi, svuotato completamente del suo significato (13).
In particolare, il diritto di famiglia, ovvero l'insieme delle
leggi che regolano i rapporti tra uomini e donne in tema di matrimonio,
divorzio e tutela dei minori, sono rimaste quelle elaborate nelle
società altamente misogine dei primi tre o quattro secoli
dell'Islam e sono tuttora, in alcune nazioni, profondamente refrattarie
al cambiamento.
I discendenti dei legislatori del primo periodo dell'Islam hanno
ripristinato, oggi, leggi, concepite in altre epoche ed in altre
società, che escludono volutamente -quando si tratti delle
donne- le idee contemporanee sulla giustizia e sui diritti umani,
pur adottando linguaggi e tecnologie moderni in ogni altra sfera
della vita sociale.
L'ineguaglianza dei sessi, d'altronde, è utilizzata strumentalmente
per riprodurre, garantire e preparare l'ineguaglianza politica
e, paradossalmente, riaffermarla come fondamento dell'essere
culturale, come identità ...(14)
L'Islam moderno è incapace di sentire l'uguaglianza come
caratteristica endogena.
La questione della donna dimostra concretamente come da un lato
sia mancata l'elaborazione di schemi teorici che identifichino
i principi di base dell'Islam in quanto filosofia, in quanto
civiltà-visione del mondo, dall'altro ciò abbia
avallato la prevalenza di un dell'Islam vissuto, ovvero che presiede
ai rapporti quotidiani, malato di amnesia.
"Gli uomini sottomessi e le donne sottomesse,
gli uomini credenti e le donne credenti,
gli uomini pii e le donne pie,
gli uomini sinceri e le donne sincere,
gli uomini pazienti e le donne pazienti,
gli uomini che temono Allah e le donne che temono Allah,
gli uomini che fanno l'elemosina e le donne che fanno l'elemosina,
gli uomini che digiunano e le donne che digiunano,
gli uomini che proteggono il loro apparato sessuale e le donne che proteggono il loro,
quelli che invocano molto Allah e quelle che fanno lo stesso.
Ecco coloro per i quali Allah ha preparato un perdono ed una ricompensa senza limite"
Corano (33,35)
In tema di diritti umani, in particolare, va segnalata la
Dichiarazione del Cairo sui diritti umani dell'Islam (1990)
adottata nel quadro della Convenzione della Lega degli Stati
arabi. In questo testo si riafferma "il ruolo civilizzatore
e storico della Ummah islamica che Dio fece quale migliore nazione"
di cui si rivendica la missione in una "umanità confusa
da orientamenti e ideologie contradditorie e per fornire soluzioni
ai cronici problemi dell'attuale civiltà materialistica"
(15). Al contrario delle Dichiarazioni e Convenzioni adottate
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in un contesto più
ampio, il Consiglio Islamico ha basato le sue argomentazioni
facendo esclusivamente riferimento al dogma religioso.
Così, molti paesi islamici stanno cercando di adeguarsi
ai principi dei diritti umani sanciti dalla carta delle N.U.,
mentre altri paesi hanno subito una involuzione (ed è
il caso dell'Afghanistan) determinando un effetto devastante
nel proprio sistema sociale, economico e politico, e confliggendo
con la comunità internazionale (16).
La sfida, oggi, sembra essere quella del rapporto e della combinazione
tra Universalità dei diritti umani e relatività
delle culture, il perpetrare certi schemi culturali e religiosi
giustificati socialmente e applicati a livello giuridico, infatti,
rende problematica la disapplicazione delle norme e dei principi
che li compongono anche qualora siano percepiti dagli stessi
musulmani come inappropriati ed obsoleti (17).
3.3 LA CONDIZIONE FEMMINILE IN AFGHANISTAN
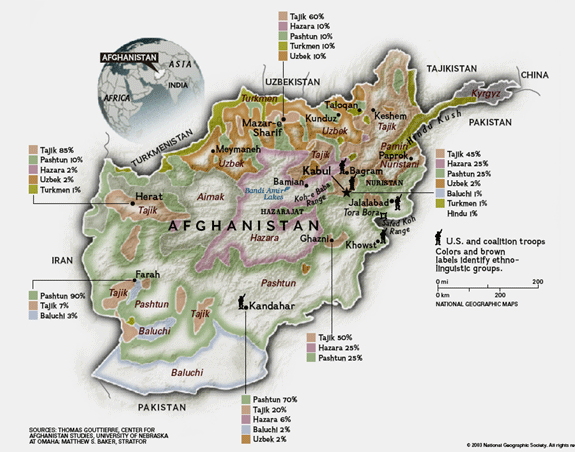
Presidente del governo di transizione: Hamid Garzai
Pena di morte: mantenitore
Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: ratificata
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite
sulle donne:
non firmato(18).
Cronologia essenziale (19):
1919: L'Afghanistan ottiene l'indipendenza dalla Gran Bretagna.
Seguono dieci anni di monarchia sotto il re Amanullah, il quale
avvia una serie di innovazioni e aperture verso l'occidente
dichiara la parità dei sessi, ordina la soppressione della
schiavitù, inaugura la prima scuola femminile, nel 1928
abolisce l'obbligo del velo attirando su di sé l'ostilità
del clero che lo costringerà nel 1929 ad abbandonare il
suo paese.
1929: Appoggiato dagli inglesi, sale al trono un lontano
parente di Amanullah, Nader Khan che dopo tre anni di terrore
è assassinato da uno studente.
1933: Eredita il trono Zahir Shah, figlio di Nader Khan,
che regna sull'Afghanistan per i successivi 40 anni.
1953: Il generale Mohammed Daud, cugino del re, viene
nominato Primo Ministro e stringe legami con l'Unione Sovietica
per ottenere aiuti militari. Nel frattempo avvia una serie di
riforme volte alla sovietizzazione del paese. Il purdah, ovvero
la reclusione delle donne in spazi separati, e l'obbligo del
velo vengono resi facoltativi.
1964: L'Afghanistan diventa una monarchia costituzionale.
1965: Viene fondato il Partito Comunista Afgano (PDPA).
1973: Daud, appoggiato dal partito comunista afgano, rovescia
il governo del re Zahir Shah, abolisce la monarchia e si proclama
Presidente della Repubblica Afgana.
1978: Con un colpo di stato appoggiato dall'URSS, Daud
viene assassinato. Le tensioni all'interno del PDPA aumentano
sempre più e, contemporaneamente, nasce il movimento armato
e conservatore dei Mujaheddin che sancisce l'inizio della Jihad
(la guerra santa).
1980: Babrak Karmal, del partito democratico afgano, diviene
presidente con l'aiuto decisivo dell'Urss che, subito dopo, invade
il paese provocando l'inizio delle prime ondate di profughi verso
Pakistan e Iran. Nel frattempo, e forze di resistenza dei vari
movimenti di opposizione islamica si intensificano, finanziate
da USA, Pakistan, Cina, Iran e Arabia Saudita.
1986: Babrak Karmal è sostituito da Najibullah,
che ha vissuto in URSS e diretto per anni i servizi segreti afgani.
1987: Meena, leader e fondatrice della Rawa viene assassinata
probabilmente da agenti del KGB ( servizi segreti sovietici).
1989: I sovietici si ritirano dal paese ma la guerra dei
mujaheddin continua contro il governo filosovietico di Najibullah.
Osama Bin Laden apre la sua base "Al-Qaeda" a Peshawar.
1992: I mujaheddin occupano Kabul. Si forma una Stato
Islamico con Rabbani, tagiko, come presidente. Ma, a causa della
politica moderata del presidente, continuano tra i vari signori
della guerra i conflitti armati che portano ad una vera e propria
guerra civile (1992-94).
1994: Nasce nelle madrase (scuole coraniche) del Pakistan
il movimento islamico dei Talibani, musulmani sunniti d etnia
pathan, che cominciano ad entrare in scena dirimendo i conflitti
tra i mujaheddin che dilaniano il paese.
1996: I talebani conquistano Kabul e qui insediano una
vera e propria dittatura integralista basata sulla stretta osservanza
della sharia, la legge islamica da loro tradotta, che prevede
fustigazioni, lapidazioni e, in particolare, la privazione dei
più elementari diritti umani alle donne, come, ad esempio,
l'imposizione del burqa. Rabbani fugge e guida assieme al generale
Massud, la guerra anti-talebana dei mujaheddin compattatisi nell'Alleanza
del Nord.
1997: L'emirato islamico dei talebani viene riconosciuto
soltanto dall'Arabia Saudita, il Pakistan e gli Emirati Arabi
Uniti. Nei due anni successivi il paese arriva al collasso del
suo sistema educativo, l'economia ruota intorno all'esportazione
di oppio, aumenta la povertà a causa della siccità
e vengono redatte denunce da parte di tante organizzazioni umanitarie
sulle vessazioni di ogni genere perpetrate alla popolazione,
soprattutto, femminile.
2001: Il generale Massud viene assassinato. Subito dopo,
l'attacco agli Stati Uniti dell'11 settembre determina l'intervento
della forza americana nel paese e l'ennesima guerra che si conclude
con la cacciata dei talebani. A dicembre si tiene il primo Summit
sulla democrazia delle donne afghane (Afghan Women's Summit for
Democracy- Brussels) e la conferenza di Bonn a seguito della
quale viene insediato a Kabul un governo ad interim capeggiato
da Hamid Karzai e composto soprattutto da ministri dell'Alleanza
del Nord. Sono presenti anche due donne, Sima Samar e la ministra
per la salute.
2002: Tra il 10 e il 22 giugno si tiene la Loya Jirga,
l'assemblea dei capi tribù, per decidere quale governo
porterà tra due anni a elezioni democratiche l'Afghanistan.
Per la prima volta nella storia 160 seggi sono occupati da donne.
Viene riconfermato Karzai come Primo Ministro del governo di
transizione.
2003: L'afghanistan ratifica la Convenzione sull'eliminazione
di ogni forma di discriminazione verso le donne" (CEDAW).
Si apre un'altra sessione della Loya Jirga per deliberare sulla
nuova costituzione. Nel frattempo, Lakhdar Brahimi dichiara prematura
la data delle elezioni fissata per giugno a causa della continua
instabilità nelle varie province dei signori della guerra.
2004: Il 26 gennaio Hamid Karzai approva la nuova costituzione
che prevede uguali diritti per uomini e donne e l'Islam come
religione di Stato con la garanzia di tutelare la convivenza
pacifica con tutte le altre presenze religiose. Habiba Sarabi,
dell'Hawca (..) è stata nominata al posto di Sima Samar,
accusata di blasfemia contro la sharia. L'ex ministra è
divenuta presidente della Commissione Diritti Umani. In agosto
sono ricominciati gli attentati a Kabul ed in tutto il paese
c'è ancora uno stato di guerra permanente, i soldati americani
ed inglesi sono ancora presenti sul territorio. In ottobre sono
previste le prime elezioni "democratiche".
La situazione delle donne in Afghanistan rappresenta, probabilmente,
l'abuso contro i diritti delle donne più severo ed estremo
al mondo.
L'Afghanistan, da un punto di vista prettamente storico, è
un paese tribale, patriarcale, basato sulla pastorizia nomade
e l'agricoltura stanziale e organizzato secondo linee patrilineari,
in cui i ruoli di genere e la condizione femminile sono connessi
ai rapporti di proprietà (20). Inoltre, ha una posizione
strategica al centro dell'Asia, rappresenta, infatti, la migliore
zona di transito per recuperare il petrolio ed il gas degli enormi
giacimenti dell'area, farlo arrivare al mare e da lì al
resto dell'Asia e all'Occidente, e per questo è stato
ed è, tuttora, terreno di battaglia di molti interessi
e soggetto di una serie di interferenze straniere (in particolare
degli Stati Uniti) (21). Prima della guerra civile degli ultimi
venti anni, il paese, considerate le sue radici culturali, non
rappresentava certo un baluardo di parità dei sessi, ma
cominiciò a dimostrare un crescente impegno per i diritti
delle donne. Secondo Amnesty International, nel 1960, il governo,
sotto la leadership del primo ministro Daoud Khan, considerò
il velo come facoltativo e concesse alle donne gli stessi diritti
e doveri di fronte alla legge, compreso, quindi, il diritto di
votare e partecipare attivamente alla vita politica della comunità.
Durante l'occupazione sovietica (1979-89) furono poi avviate
una serie di riforme volte alla sovietizzazione e laicizzazione
del territorio, l'età minima del matrimonio, ad esempio,
fu alzata e fu attribuita una grand'enfasi al ruolo dell'istruzione,
cui seguì la creazione di numerosi corsi di alfabetizzazione
anche per bambine (22). È in questo contesto che cominciò
ad organizzarsi la resistenza islamica che farà precipitare
L'Afghanistan in uno stato di forte instabilità e devastazione
all'insegna di una guerra civile permanente per oltre vent'anni.
Con la salita al potere dei fondamentalisti Jehadi nel 1992,
il diritto delle donne di partecipare pienamente alla vita sociale,
economica, politica e culturale del paese fu drasticamente ridotto
e, in seguito, con l'ascesa dei talebani, completamente negato.
Sotto questi ultimi, e attraverso il lavoro di controllo dei
membri del Dipartimento per la promozione della virtù
e la prevenzione del rischio, le donne sono state totalmente
private del diritto all'istruzione (tutte le scuole femminili
sono state, infatti, chiuse), del diritto al lavoro, del diritto
di spostarsi se non accompagnate da un parente di sesso maschile
(mahram), del diritto alla salute (nessuna donna può essere
visitata da un medico di sesso maschile), del diritto di ricorrere
alla legge (una donna può fare ricorso ad un tribunale
solo tramite un membro scelto della sua famiglia, inoltre, la
sua testimonianza vale la metà di quella di un uomo) e
persino del diritto a divertirsi (non si può cantare,
ad esempio, perché la voce di una donna può "provocare"un
uomo) (23). Le donne "non in regola" sono state torturate,
picchiate, stuprate e giustiziate pubblicamente (24).
Gli abusi dei diritti delle donne perpetrati dai talebani sono
stati ampiamente documentati. Nel 1998, ad esempio, un report
redatto dalla Commissione per lo status della donna su pratiche
e diritti umani denunciò l'effetto devastante delle azioni
del regime integralista sulla loro salute fisica e psicologica
(25).
Il mondo, però, ha ignorato la tragedia del popolo afghano,
in particolare di quello femminile, fino all'undici settembre
del 2001. Con la caduta delle Torri Gemelle, la potenza militare
americana si è rimessa in moto (26) e il popolo afghano,
già prigioniero, affamato, devastato e colpito dalla siccità
è stato bombardato con le armi più sofisticate
mai costruite nella storia dell'umanità per essere "liberato"
dall'oppressivo regime integralista (27).
Ma non è bastata la fuga dei talebani per liberare le
donne dal burqa.
Giuliana Sgrena, giornalista del manifesto particolarmente sensibile
alla spinosa questione delle donne afghane, al riguardo sostiene
che "forse era impensabile che ciò potesse accadere,
e tantomeno si poteva immaginare che una guerra potesse favorire
la liberazione delle donne o ovviare con fermezza un processo
d'emancipazione come hanno cercato di far credere i fautori del
conflitto in Occidente"(28).
Come stabilito negli accordi della Conferenza di Bonn (dicembre
del 2001), sotto l'egida degli Stati Uniti, è stato insediato
a Kabul un governo ad interim (ATA, Afghan Transitional Administration)
presieduto da Hamid Karzai, tuttora in carica, e composto soprattutto
da ministri dell'Alleanza del Nord, ma anche da alcune donne,
come la ministra per le donne Habiba Sarabi e la ministra per
la salute Suhaila Seddiqui (29) , seppure, la crisi umanitaria
afghana non può certo essere risolta con la creazione
di un "Ministero per gli Affari Femminili", né
con l'attribuzione simbolica di alte cariche governative ad un
paio di donne.
I clamori mediatici sollevati intorno alla cosiddetta lotta al
terrorismo hanno portato alla luce i crimini commessi e sollecitato
l'intervento della comunità internazionale tanto auspicato
dalla società civile del paese, ma, come sostengono chiaramente
in molti documenti le militanti dell'Organizzazione Rivoluzionaria
delle donne Afghane, è stato messo da parte il fatto che
molti signori della guerra dell'Alleanza del Nord sono essi stessi
combattenti religiosi. Non solo attuarono una forte repressione
delle donne quando ebbero il potere dal 1992 al 1996, ma gettarono
il paese nella guerra civile, segnando un record per gli omicidi
di massa motivati dall'appartenenza etnica (30).
Mujaheddin e talebani condividono la medesima ideologia integralista
e misogina ed è poco realistico sperare di ottenere libertà,
democrazia e uguaglianza in un sistema corrotto, sciovinista
e fondato sulla religione.
La sharia (legge islamica) è ancora in vigore, l'incidenza
degli stupri e del matrimonio forzato è di nuovo in ascesa,
e la maggior parte delle donne continua ad indossare il burqa
per ragioni di sicurezza personale.
Due recenti rapporti di Human Rights Watch (2002)(31) e di Amnesty
International (2003)(32) affermano che in Afghanistan si sta
tornando indietro.
Åg Da circa due anni discriminazione, violenza ed
insicurezza sono ancora diffuse malgrado le promesse dei governi
internazionali, compresi il presidente degli Stati Uniti Gorge
Bush e il segretario di stato Colin Powell, che la guerra
in Afghanistan avrebbe portato la liberazione delle donne"
(33).
Come evidenziato all'inizio del paragrafo, nel marzo del 2004
le autorità afghane hanno ratificato senza riserve la
Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne compiendo
un importante passo in avanti per i diritti legali delle donne.
Tuttavia la profonda ineguaglianza tra uomini e donne rimane
sancita fermamente nella legislazione interna soprattutto per
ciò che riguarda le norme relative a matrimoni e divorzi.
L'adulterio, la "fuga da casa" e l'attività
sessuale illecita (rapporti sessuali tra un uomo ed una donna
non sposati) -noti come zina continuano ad essere
considerati reati penali (34).
In molte comunità rurali, donne e ragazze sono ancora
valutate merce di scambio nel contesto delle risoluzioni per
controversie tra le comunità o in questioni criminali
come omicidi e rapimenti (35).
Tutto questo con il sostegno attivo o la complicità passiva
di agenti statali, gruppi armati, famiglie e comunità.
Il sistema di giustizia penale è incapace di affrontare
i problemi di violenza contro le donne e troppo carente per garantire
una concreta protezione del loro diritto alla vita ed alla sicurezza
fisica (36).
Inoltre, nonostante la ratifica a febbraio dello Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale non sono stati ancora
giudicati i responsabili dei gravi abusi del passato e la stessa
UNAMA (ovvero la missione di assistenza delle Nazioni Unite in
Afghanistan iniziata nel marzo del 2002) ha evitato la questione.
Solo la Commissione afghana indipendente per i diritti umani
(istituita nel giugno del 2002) continua a lavorare assiduamente
sul tema sebbene sia talvolta osteggiata dagli stessi funzionari
governativi (37).
Il governo Karzai, anche dopo la fine dei lavori della Loya Jirga
(38), tenutasi, comunque, in un clima di forte tensione, non
riesce a creare uno stato unitario poichè è debole,
dipendente dagli alleati statunitensi, dalla forza internazionale
(ISAF- International Save Force in Afghanistan, presente a Kabul
per mantenere pace e sicurezza dell'area) e dai suoi infidi alleati
locali (39).
Non sono stati sradicati né la coltivazione del papavero
da oppio, né il potere dilagante dei signori della guerra:
appena fuori Kabul, in un territorio infestato dalle mine, guerra,
violenze inter-etniche, droga e spartizioni di territorio continuano
ad essere quotidianità (40).
Il nodo principale, come sostengono le militanti di Rawa e tutto
il movimento di solidarietà di genere sviluppatosi intorno
alla questione afghana, continua ad essere quello della separazione
tra stato e religione che, tuttavia, non sembra ancora all'orizzonte.
La mancata distinzione tra stato e religione e la negazione dell'autonomia
dello stato di diritto costituiscono le fondamenta del potere
esercitato sulla base di un interpretazione fondamentalista del
Corano, assunta a dogma per prefigurare un controllo totale,
ovvero psico-religioso, economico e socio-culturale (41).
Al giorno d'oggi, l'integralismo/fondamentalismo islamico trova
la sua base di consenso di massa in tutti quei luoghi difficili
in cui, povertà, ignoranza e mancanza di accesso reale
a possibilità di sviluppo fanno da padrone, come nel caso
dell'Afghanistan. NOTA ATLANTE
A ciò, si aggiunge una interpretazione stereotipata e
fuorviante del fenomeno ad opera dei mass-media occidentali,
definta brillantemente da Toni Maraini, durante un colloquio
sui fondamentalismi tenutosi a Pisa nel 2000, Ågretorica
dell'etnicità"(42).
Si tratta degli effetti di una strategia ampiamente mediatizzata
- e non sufficientemente denunciata che tende a far credere
che il fondamentalismo sia connaturato a certe società
e culture e non un fenomeno che scaturisce da dinamiche connesse
con rapporti di forza socio-economici e politici, ed è
inserito in alcuni percorsi storici. Una sorta di crisi di
percezione culturale che sembra paralizzare in Occidente
l'esercizio equo delle battaglie civili, la corretta valutazione
dell'informazione e la conseguente com-partecipazione universale
della storia.
note:
(1) C.BUNCH e S.FROST, I diritti umani delle donne, traduzione a cura di Maria G. DI RIENZO, gennaio 2001, documento elettronico disponibile all'indirizzo www.ecn.org/reds/donne/cultura/formazionedirittihdonne.html
(2) Per maggiori approfondimenti sul tema della violazione dei diritti delle donne tuttora perpetrate, si può consultare l'Atlante di Le monde diplomatique/ il Manifesto, edizione italiana a cura di S.LIBERTI e G.RAGOZZINO, Roma, 2004. In rete sono, inoltre, consultabili i siti: www.unifem.org, www.genderstats.worldbank.org, www.whrnet.org (Women's Human Rights Watch Net).
(3) Città del Messico 1975; Copenhagen 1980; Nairobi 1985; Pechino 1995, seguita nel giugno 2000 dalla cosiddetta " Pechino+5", ossia dalla sessione speciale dell'assemblea Generale dell'Onu sullo stato di implementazione della piattaforma di Azione adottata a Pechino.
(4) D.DE LORENZI e S.SACCARDI, Dizionario-Atlante dello sviluppo umano, pubblicazione dell'Associazione "differenze culturali e non violenza"finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del progetto "Archivio e sviluppo", Litografia IP, Firenze, settembre 2003
(5) C.BUNCH e S.FROST, op.cit, p.5
(6) C.BUNCH e S.FROST, op.cit
(7) L.AHMED, La donna nell'Islam da Maometto agli ayatollah, La nuova Italia, Milano, settembre, 2001, p.274
(8) F.MERLISSI, Donne del Profeta: la condizione femminilenell'Islam, Ecig, Genova, 1992, p.217
(9) Per risolvere il problema della Shari'a, la legge sacra, che incarna, rappresenta ed esprime la volontà divina, gli esperti elaborarono una scienza religiosa, il Fiqh. Si tratta di badare al controllo dell'interpretazione del Qor'an, il testo rivelato, da una parte, e, dall'altra, di stabilire la Sunna (tradizione) del Profeta mettendo per iscritto gli Hadith, ovvero tutto ciò che il Profeta ha detto per illuminare la via dell'Islam.
(10) DONNE IN NERO, La voce delle donne libere in Afghanistan, Promograph Comunication srl, Roma, febbraio, 2003, p.58
(11) L.AHMED, op.cit., p.276
(12) I fondatori della scienza religiosa considerano il versetto 53 della sura 33 la base dell'istituzione dello Hijab. Questo versetto non è l'unico a riferirsi all'evento, ma è il primo di una serie che, di fatto, ha portato ad una scissione dello spazio musulmano in due universi, quello dell'interno (il focolare domestico), e quello dell'esterno (lo spazio pubblico)
(13) 58 F.MERLISSI, op.cit., p.111 (14) 59 Idem, p.29
(15) D.DE LORENZI e S.SACCARDI, op.cit., p.44
(16)NAZIONI UNITE "Traites multilateraux deposes aupres du segretarie general", situazione al 31/12/1991, New York, 1992, p.174-181
(17) DONNE IN NERO, op.cit., p. 74
(18) AMNESTY INTERNATIONAL, Rapporto annuale 2004: Afghanistan, disponibile in formato elettronico all'indirizzo del sito ufficiale dell'organizzazione umanitaria www.amnesty.org
(19) Fonti: Donne in nero, op.cit., p. 142; Women-war-peace, Rapporto sull'Afghanistan 2004, documento disponibile in formato elettronico all'indirizzo www.womenwarpeace.org/afghanistan/afghanistan.htm
(20) Intervento di D.COLOMBO, Presidente dell'AIDOS, al convegno "Donne afgane: il diritto di vivere", organizzato dalla Commisione Nazionale Pari Opportunità, Roma, palazzo S.Marino, novembre, 2001
(21) Per eventuali approfondimenti sui particolari interessi di potere attorno all'Afghanistan è molto interessante il documento del gruppo di studio "Guerra e pace", intitolato "Afghanistan: la storia vera", Pubblicazioni Centro Studi per la Pace, dicembre, 2003. Disponibile anche in formato elettronico all' indirizzo www.studiperlapace.it/documentazioni/afghanistan.html.
(22) K.RICHTER, Storia recente dell'Afghanistan e della RAWA, documento elettronico disponibile all'indirizzo www.rawa.fancymarketing.net/zmag_it.htm
(23) RAWA, La situazione delle donne afghane, documento elettronico reperibile sul sito ufficiale dell'organizzazione www.rawa.org. Per maggiori approfondimenti sulle restrizioni imposte alle donne durante il regime dei talebani sono disponibili, allo stesso indirizzo, numerosissime testimonianze di donne afghane. In particolare, nel documento Le restrizioni ed i maltrattamenti dei talebani verso le donne, è presente una lista molto esaustiva sul tema.
(24) L'organizzazione Rivoluzionaria delle donne afghane ha realizzato un video, disponibile on-line sul sito www.rawa.org, dell'esecuzione di una donna in uno stadio che oltre ad essere molto impressionante rappresenta una efficace testimonianza di quanto avvenuto in Afghanistan in questi ultimi anni.
(25) DONNE IN NERO, op.cit, p.75
(26) Per approfondire sulle commistioni degli Stati Uniti con gli affari interni del paese attraverso finanziamenti militari ai vari "signori della guerra" in lotta per l'indipendenza dall'ex Unione Sovietica, si può consultare il libro di G.CHIESA, VAURO e G.STRADA, Afghanistan:anno zero, Guerini e Associati editore, Milano, 2001
(27) DONNE IN NERO op.cit., p.70
(28) G.SGRENA, Ricominciare in Afghanistan, in S.BARTOLINI, A volto scoperto. Donne e diritti umani, Manifestolibri, giugno, 2002, p.195
(29) DONNE IN NERO op.cit, p.150
(30) K. POLLITT-RAWA, The Nation Magazine,Column ottobre 22, 2001. Traduzione a cura di P. GUIDO, in DONNE IN NERO, op.cit., p.32
(31) HUMAN RIGHTS WATCH, Coprirsi:le donne in Afghanistan dopo i talebani, rapporto redatto nel maggio del 2002, disponibile in formato elettronico sul sito ufficiale dell'osservatorio all'indirizzo www.hrw.org/backgrounder/wrd/afghan-women-2k2.htm
(32) AMNESTY INTERNATIONAL, Afghanistan:nessuno ci ascolta e nessuno ci tratta come esseri umani. La giustizia negata alle donne, rapporto redatto nell'ottobre del 2003, disponibile in formato elettronico sul sito ufficiale dell'organizzazione non governativa all'indirizzo www.web.amnesty.org/library/index/engasa110232003
(33) AMNESTY INTERNATIONAL, Afghanistan, niente sicurezza e giustizia per le donne, ottobre, 2003, articolo disponibile on-line all'indirizzo www.rawa.org/it/ai-women2_it.htm
(34) AMNESTY INTERNATIONAL, Rapporto annuale 2004: Afghanistan, disponibile in formato elettronico all'indirizzo del sito ufficiale dell'organizzazione umanitaria www.amnesty.org
(35) Idem, p 4
(36) Idem, p 4
(37) Idem, p 2
(38) La Loya Jirga è il Consiglio di governo che ha deciso della nuova costituzione nel dicembre del 2003. Le attiviste afghane per i diritti umani hanno seguito il processo di elaborazione della nuova costituzione, che non garantisce esplicitamente i diritti delle donne: non è dichiarata la parità di diritti tra uomini e donne, non viene indicata un'età minima per il matrimonio o la parità di diritti in caso di divorzio. Le donne avevano, inoltre, inutilmente chiesto che la Costituzione fissasse il divieto alla schiavitù. Per approfondire sulla scandalosa atmosfera poliziesca durante l'assemblea dei capi tribù si può consultare il sito ufficiale della Rawa all'indirizzo http://rawa.fancymarketing.net/loyajirga_it.htm, e l'articolo della rivista settimanale Carta, Afghanistan:burqa costituzionale, del 19/12/2003, disponibile in formato elettronico all'indirizzo http://www.carta.org/cartamondo/archivio/asia/031219afghanistan.htm.
(39) DONNE IN NERO op.cit., p. 154
(40) C.CATTAFESTA, F.FLUMERI, L.QUAGLIOLO, I.STEFANI, Nasreen e le altre, in DONNE IN NERO, op.cit., p. 55
(41) T.MARAINI, Per una riflessione sui fondamentalismi oggi, testo rivisto e corretto nell'agosto del 2002, in DONNE IN NERO, op.cit., p. 61
(42) T.MARAINI, in DONNE IN NERO, op.cit., p. 68
